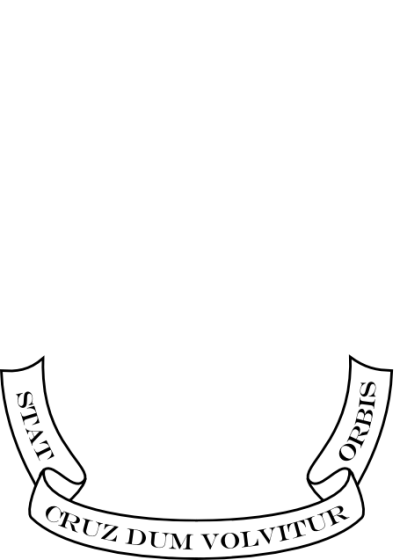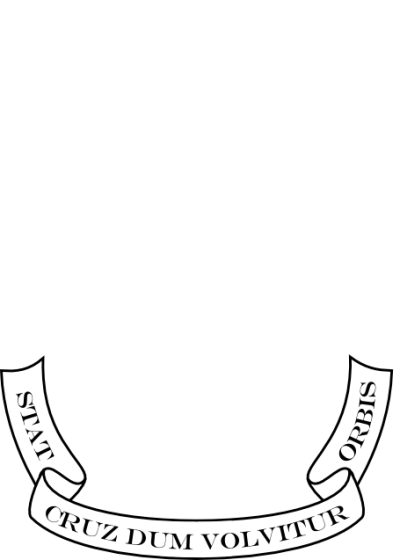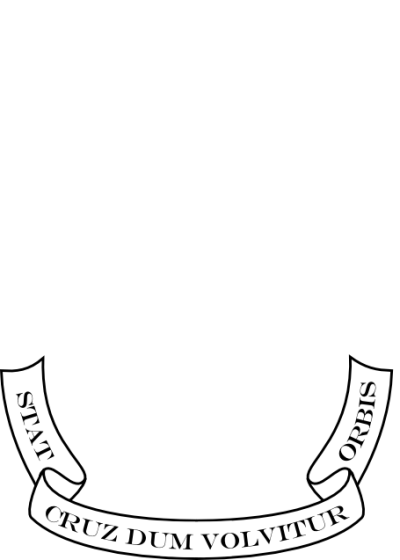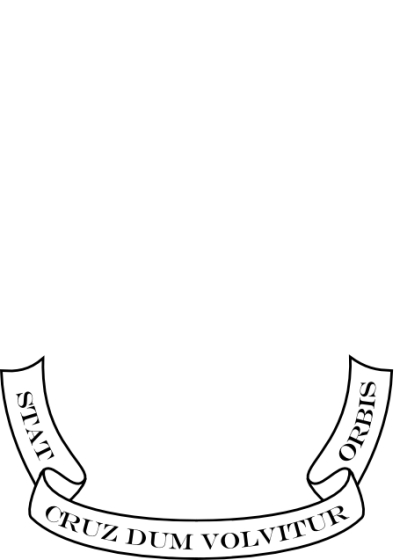Chiesa di San Girolamo della Certosa - Ieri
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per i restauri. Fai una donazione. Grazie!
Cristo crocifisso
La chiesa di San Girolamo - Pdf
Cappella di San Bruno
Cappella di San Girolamo
Navata
Introduzione - Niccoló Albergati
Cappella dell´Annunziata
Cappella e Altare di San Bruno
Posta a destra dell'ingresso, la cappella di S. Bruno era in origine dedicata a San Giovanni Battista e ospitò la grande pala rappresentante la Predica del santo di Ludovico Carracci, oggi alla Pinacoteca nazionale. Successivamente intitolato a S. Bruno venne ornata con il dipinto del Guercino (1591 - 1666) La Vergine appare a S. Bruno, anch'esso trasferito alla Pinacoteca Nazionale. Attualmente nell'ancona cinquecentesca di linee classiche si trova l'Apparizione di Cristo a S. Bruno, attribuito al Cesi (1566 - 1629), ma pesantemente ritoccato da Filippo Pedrini nel XIX secolo. Ai lati della pala d'altare sono appesi i due Evangelisti Giovanni e Luca, opera del pittore napoletano Nunzio Rossi (1626 - 1651). Sulle pareti laterali si fronteggiano i due grandi dipinti con l'Ascensione (1651), di Francesco Galli Bibiena (1618/19 – 1665) e il Giudizio Finale (1658), di Domenico Maria Canuti (1620-1684), affiancati da coppie di quadri a olio centinati con figure di beati certosini, opera degli stessi autori. Al centro del pavimento la grata in ferro battuto dà accesso alla cripta della famiglia Pallavicini. Nella chiave di volta è affrescata la figura di S. Bruno.Antonella MampieriApprofondimenti: [Storia e memoria di Bologna](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-e-altare-di-san-bruno-846-opera)
Cappella e altare di San Girolamo
Nella grande ancona d'altare cinquecentesca è posta la copia che Clemente Alberi (1803 - 1864) trasse dalla pala di Agostino Carracci (1557 - 1602) raffigurante l'Ultima Comunione di San Girolamo. La copia fu donata alla chiesa di San Girolamo dal principe Spada nel 1825, come risarcimento per la perdita dell'originale, trasferito alla Pinacoteca nazionale in seguito alle soppressioni. Ai lati dell'ancona sono appesi gli Evangelisti Matteo e Marco del pittore napoletano Nunzio Rossi (1626 - 1651). Sulle pareti si fronteggiano La Cena in Casa del Fariseo (1652) di Giovanni Andrea Sirani (1610 - 1670) e Il Battesimo di Cristo (1658), prima opera pubblica di sua figlia Elisabetta (1638 - 1665). Ai lati dei due dipinti si trovano coppie di tele centinate raffiguranti beati certosini, opera degli stessi autori. Sotto il Battesimo di Cristo si trova il monumento sepolcrale in marmo al cardinale Moretti (1882), scolpito da Enrico Barberi (1850 -1941). Nella chiave di volta è affrescata la figura di S. Girolamo.Antonella MampieriApprofondimenti: [Storia e memoria di Bologna](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-e-altare-di-san-girolamo-847-opera)
Coro intarsiato
Cappella delle Reliquie
Catene Ex voto
Catene Ex voto
Cappella di San Giuseppe
Via Crucis - Giuseppe Leonardi (attribuito) 1750 - 1820
Catene Ex voto
Nelle cappelle laterali dell'Annunziata, delle Reliquie e di San Giuseppe sono appese molte catene ex-voto di cristiani caduti in mano ai turchi, fatti schiavi e riscattati dalla Confraternita bolognese della Madonna Auxilium Christianorum, trasferite dall’oratorio della Madonna della Neve dopo la sua soppressione. Ogni catena è accompagnata da una tabella lignea che indica il nome del prigioniero riscattato, l’anno del riscatto e la somma pagata per la sua liberazione. Dopo il recente restauro sono divenute completamente leggibili le scritte, che però sono risultate ridipinte successivamente sulla stesura originaria, con diverse modifiche anche nella forma dei cartigli. Questi ex-voto confluiscono nella Chiesa di san Girolamo in seguito alle soppressioni ecclesiastiche ottocentesche, e si aggiungevano alle numerose memorie provenienti dalle chiese soppresse (affreschi, tombe monumentali, lapidi), collocate nei vari ambienti dell'ex monastero cartusiano, trasformato nel 1801 in cimitero comunale.Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/catene-ex-voto-852-opera)
Catene Ex voto
Nelle cappelle laterali dell'Annunziata, delle Reliquie e di San Giuseppe sono appese molte catene ex-voto di cristiani caduti in mano ai turchi, fatti schiavi e riscattati dalla Confraternita bolognese della Madonna Auxilium Christianorum, trasferite dall’oratorio della Madonna della Neve dopo la sua soppressione. Ogni catena è accompagnata da una tabella lignea che indica il nome del prigioniero riscattato, l’anno del riscatto e la somma pagata per la sua liberazione. Dopo il recente restauro sono divenute completamente leggibili le scritte, che però sono risultate ridipinte successivamente sulla stesura originaria, con diverse modifiche anche nella forma dei cartigli. Questi ex-voto confluiscono nella Chiesa di san Girolamo in seguito alle soppressioni ecclesiastiche ottocentesche, e si aggiungevano alle numerose memorie provenienti dalle chiese soppresse (affreschi, tombe monumentali, lapidi), collocate nei vari ambienti dell'ex monastero cartusiano, trasformato nel 1801 in cimitero comunale.Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/catene-ex-voto-852-opera)
Coro intarsiato - Gli stalli di destra
Certosa di Bologna, Chiesa di San Girolamo. Veduta d'insieme del coro intarsiato, datato 1538. Foto Oriana Palermo.Venne realizzato tra il 1538 e il 1539 da Biagio De Marchi da Crema , la cui famiglia aveva lavorato in precedenza al coro della certosa di Pavia. Biagio De Marchi si firma nei primi due stalli a sinistra e a destra dell’ingresso, su cui sono rappresentate le figure di san Girolamo e di san Giovanni Battista, rispettivamente l’eponimo a cui era dedicata la chiesa e il santo protettore dei certosini. Il coro con i suoi stalli intarsiati rappresentanti nature morte, prospettive architettoniche, figure di santi, sostituisce quello quattrocentesco di Melchiorre Provenzali da Cento che era stato distrutto nel 1527 dai lanzichenecchi di Carlo V. Completano il coro intarsiato due splendidi elementi che erano situati in origine nel presbiterio: il leggio, da cui il diacono annunciava il Vangelo, e la cattedra del celebrante. Nello sportello del leggio è raffigurato san Giovanni Evangelista nell’atto di scrivere l’inizio del suo Vangelo, assistito dal suo animale simbolico, l’aquila, nella parte alta si trova un angelo in volo. Sulla cattedra del celebrante lo stallo rappresenta San Petronio seduto davanti al quale è inginocchiato il beato Niccolò Albergati, certosino e vescovo di Bologna.Antonella Mampieri[Vedi gli stalli di destra - Panocticon di Bologna](http://www.panopticondibologna.it/ga1/CORO/dxt0%20menu.html)Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it ](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/coro-intarsiato-866-opera)
Coro intarsiato - Gli stalli di sinistra
Venne realizzato tra il 1538 e il 1539 da Biagio De Marchi da Crema , la cui famiglia aveva lavorato in precedenza al coro della certosa di Pavia. Biagio De Marchi si firma nei primi due stalli a sinistra e a destra dell’ingresso, su cui sono rappresentate le figure di san Girolamo e di san Giovanni Battista, rispettivamente l’eponimo a cui era dedicata la chiesa e il santo protettore dei certosini. Il coro con i suoi stalli intarsiati rappresentanti nature morte, prospettive architettoniche, figure di santi, sostituisce quello quattrocentesco di Melchiorre Provenzali da Cento che era stato distrutto nel 1527 dai lanzichenecchi di Carlo V. Completano il coro intarsiato due splendidi elementi che erano situati in origine nel presbiterio: il leggio, da cui il diacono annunciava il Vangelo, e la cattedra del celebrante. Nello sportello del leggio è raffigurato san Giovanni Evangelista nell’atto di scrivere l’inizio del suo Vangelo, assistito dal suo animale simbolico, l’aquila, nella parte alta si trova un angelo in volo. Sulla cattedra del celebrante lo stallo rappresenta San Petronio seduto davanti al quale è inginocchiato il beato Niccolò Albergati, certosino e vescovo di Bologna.Antonella Mampieri[Vedi gli stalli di sinistra - Panocticon di Bologna](http://www.panopticondibologna.it/Luoghi/certosa%20San%20Girolamo/CORO/sin0%20menu.html)Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/coro-intarsiato-866-opera)
Sacrestia
Dalla cappella maggiore si accede alla sacrestia, caratterizzata da imponenti armadi lignei. Al centro dell'altare dalle ricche colonne tortili in stucco bianco e dorato, si trova un crocefisso in legno tra la Madonna e San Giovanni Evangelista in terracotta policroma, attribuibili a scuola bolognese del XVIII secolo. All'epoca della sistemazione della cappella maggiore ad opera del Cesi fu trasferito in sacrestia il polittico realizzato per l'altar maggiore, commissionato da papa Niccolò V ai pittori veneziani Bartolomeo (1432- 1499) e Antonio Vivarini (1415 - 1484)), oggi alla Pinacoteca Nazionale. Sulla parete di sinistra sono appesi il dipinto di Ercole Graziani (1688-1765) Il Beato Nicolò Albergati appare in sogno a Tommaso Parentucelli, proveniente da una delle cappelle laterali e Il Crocefisso tra la Vergine, San Giovanni Evangelista ed un altro santo attribuito a scuola bolognese della seconda metà del Cinquecento. Sopra la porta che conduce alla cappella di San Giuseppe si trovava un sottoquadro attribuibile al Calvi (1740-1815) raffigurante S. Bruno, ora posto sull'altare della Cappella di San Girolamo. Sulla parete destra si trovano La Madonna col Bambino, S. Caterina e S. Ugo Vescovo di Girolamo Bonesi (1653 - 1725) trasferito in sagrestia da altri locali del convento o della chiesa. Era qui collocato anche un Santo Certosino di scuola bolognese, ora nella cappella dell'Annunciazione. Accanto all'altare era collocato un leggio dipinto sui tre lati con grottesche e bizzarrie di gusto cinquecentesco rivelatosi opera di Amico Aspertini. Le tavole dopo il restauro sono state collocate nella Cappella delle Reliquie.Antonella MampieriVedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/sacrestia-2066-opera)
Coro dei conversi
L'ipotesi di Bastelli e di Raule secondo la quale questi stalli sarebbero quelli sopravvissuti del coro quattrocentesco bruciato dai lanzichenecchi di Carlo V nel 1527, sembra non essere stata accolta da Massimo Medica. Quest'ultimo, infatti, non chiama in causa i presenti stalli quando ipotizza che il coro originario, realizzato dai Provenzali nel 1488, fosse "riccamente ornato da intagli e raffinate tarsie" che sarebbero stati in parte riutilizzate nel corso della realizzazione del nuovo coro realizzato da Biagio de Marchi nel 1538 e poi ampliato nel 1612 (Mazza 1998; Marzocchi 1998). Non si può escludere che questi stalli provengano da una qualche chiesa soppressa.Vedi altro: [Beni Culturali](https://www.beni-culturali.eu/opere_d_arte/scheda/-08-00068280/137014)
Coro dei conversi
L'ipotesi di Bastelli e di Raule secondo la quale questi stalli sarebbero quelli sopravvissuti del coro quattrocentesco bruciato dai lanzichenecchi di Carlo V nel 1527, sembra non essere stata accolta da Massimo Medica. Quest'ultimo, infatti, non chiama in causa i presenti stalli quando ipotizza che il coro originario, realizzato dai Provenzali nel 1488, fosse "riccamente ornato da intagli e raffinate tarsie" che sarebbero state in parte riutilizzate nel corso della realizzazione del nuovo coro realizzato da Biagio de Marchi nel 1538 e poi ampliato nel 1612 (Mazza 1998; Marzocchi 1998). Non si può escludere che questi stalli provengano da una qualche chiesa soppressa.Vedi altro: [Beni Culturali](https://www.beni-culturali.eu/opere_d_arte/scheda/-08-00068280/137014)
Quattro santi certosini
Sull'origine dei quattro dipinti è di aiuto la presenza dell'emblema cartusiano al centro dell'architrave, nel pannello principale con San Giacomo Minore. La conferma della provenienza dal convento bolognese viene da un testo presente nell'Inventario datato 1797 (Bologna, Archivio di Stato) ove viene descritta una spalierata di pioppa colorata berettina, e gialla con il suo sedile sotto, con 4° piccole statuette sotto rapp.ti Santi berretti colorati. Dopo il 1797 la 'spalierata' è stata oggetto di un'ulteriore manomissione che l'ha portata allo stato rilevato prima del restauro, coi pannelli riadattati come decorazioni per lo 'scrittoio', a sua volta incluso in maniera incongrua nel grande armadio seicentesco della sacrestia . Dal punto di vista iconografico le opere appaiono frutto di una meditata volontà celebrativa dell'ordine certosino, permeate da un'atmosfera festosamente trionfale. Il nome di Amico Aspertini è proposto come il più probabile per un'opera come questa, quasi di artigianato minore, ma per molti versi straordinaria. Un particolare estremamente interessante che riporta direttamente al pittore sono le architetture della tavola decurtata, quasi sovrapponibili alla tarsia pavimentale con il Giudizio di Salomone della chiesa di San Martino a Lucca, città dove Aspertini ha lasciato affreschi e tavole. Nel Catalogo de' Priori della Certosa … (Bologna, Archivio di Stato), in corrispondenza del priorato di Gregorio Napelli iniziato nel 1553, si ricorda come “questo fece fare le spallierate del Capitolo, dipinte con bellissime prospettive, e così parimenti l'appart.to del Priore, quello cioè d'abbasso che fu spallierato, e dipinto come l'altro dal medesimo autore”. Amico Aspertini era morto da un anno, ma un'altra notizia riportata nei “Monumenta Chronologica Cartusia Bononiensis” (Bologna, Archivio di Stato), datato 1678, consente di anticipare l'inizio dei lavori delle 'spalierate'. In questo indice annuale, al giugno 1553, viene annotato come “completum fuit ornamentum ligneum Capituli nostri”. Il Capitolo, più tardi, dovette subì modifiche significative prima con la collocazione del grande dipinto di Giovanni Maria Viani, poi verso il 1777 con quello di Ubaldo Gandolfi. I quattro pannelli ora recuperati rappresentano dunque solo un frammento di un più vasto complesso, già disperso nella memoria dell'Inventario del 1797.Roberto MartorelliFoto [Guido Barbi](https://www.guidobarbi.it/la-chiesa-di-san-girolamo-della-certosa-di-bologna/)
Cappella Maggiore
Decorata nell'ultimo decennio del Cinquecento da Bartolomeo Cesi (1566 - 1629), la cappella maggiore è un armonioso insieme di affreschi, dipinti e stucchi, bianchi e dorati. All'ingresso sono affrescati i santi Pietro e Paolo. Sull'intradosso dell'arco d'accesso, entro riquadri, sono dipinti i Santi Caterina da Siena, Domenico, Benedetto, Antonio Abate, Francesco d'Assisi e Caterina de' Vigri. Nella parte alta delle pareti sono distribuite storie del Vecchio Testamento prefiguranti il sacrificio e la resurrezione di Cristo. Sulle tre pareti dell'abside quadrata sono disposti i grandi dipinti del Cesi rappresentanti scene della Passione di Cristo inquadrati da affreschi con santi certosini. Le due porte laterali, che danno accesso al Sancta Sanctorum, sono anch'esse decorate con dipinti del Cesi raffiguranti i santi Lorenzo e Stefano. Il prezioso tabernacolo in pietre dure, originariamente collocato nel Santa Sanctorum retrostante e trasferito sull'altare solo nel secolo scorso, era ornato da statuetta in bronzo dorato di Filippo Scandellari (1717 - 1801).Antonella MampieriVedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-maggiore-845-opera)
Cappella dell'Annunziata
Entro un’ancona formiginesca si trova l’Annunciazione, dell’ambito di Bartolomeo Cesi (1566 - 1629). Il paliotto d’altare è opera successiva d’età barocca, attribuibile all’ambito di Giuseppe Mazza. Di fronte è posto il monumento al card. Bevilacqua (1888), opera dello scultore centese Stefano Galletti (1833 - 1905), ricca realizzazione in mosaico e marmi bianchi e policromi. Sulla parete a sinistra del monumento Bevilacqua si trova un affresco raffigurante S. Antonio da Padova, opera del pittore bolognese Leonardo Ferrari, detto Leonardino (morto 1648), trasportato in San Girolamo da Santa Maria della Neve. Di fronte è stato collocato un altro affresco trasportato raffigurante San Bernardino, un tempo attribuito ad Amico Aspertini e proveniente dalla chiesa soppressa del Gesù, in Via San Mamolo. Anche questa cappella è decorata dall’ornatista Luca Bistega (1672 - 1732). Accanto all’Annunziata è collocata una piccola ancona formiginesca contenente un busto policromo del Salvatore, di scultore cinquecentesco. Sopra è murata una copia del rilievo di Donatello noto come la Madonna Pazzi, oggi a Berlino. Come nelle altre cappelle anche qui sono appese le catene dei cristiani caduti in mano ai turchi, fatti schiavi e riscattati dalla Confraternita bolognese della Madonna Auxilium Christianorum, trasferite dall’oratorio della Madonna della Neve dopo la sua soppressione. Ogni catena è accompagnata da una tabella lignea che indica il nome del prigioniero riscattato, l’anno del riscatto e la somma pagata per la sua liberazione.Antonella MampieriVedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-dellannunziata-848-opera)
Cappella delle Reliquie
Decorata da Luca Bistega (1672 - 1732) come le altre di questo lato, la cappella presenta sulla parete sinistra un altare barocco per reliquiari, riccamente dorato. L'altare di fronte, di stile formiginesco, contiene un S. Francesco di Anna Mignani Grilli Rossi (morta 1832). Alle pareti sono appesi dipinti di piccolo formato, provenienti dalla Certosa stessa e da altre chiese soppresse. Nella parete di comunicazione tra questa cappella e quella di San Giuseppe si trova una piccola ancona formiginesca contenente una Madonna col Bambino in terracotta di ambito bolognese della prima metà del Cinquecento.Antonella Mampieri Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-delle-reliquie-859-opera)
Cappella di San Giuseppe
Contiene il coro intagliato che era utilizzato dai conversi. In alto è appesa l'Ultima Cena di Lorenzo Sabatini (1530 ca. – 1576), proveniente dal Refettorio del convento, oggi Sala della Pietà. La parete di fondo è occupata dall'altare settecentesco dedicato a San Giuseppe, una delle ultime opere di Giuseppe Mazza (1653-1741). Al centro di un “pannerone” in stucco sostenuto da angeli si trova la statua del santo tra San Romualdo e San Petronio, attribuibili a scuola bolognese del primo Seicento. In origine questa cappella era dedicata a San Giovanni Battista e ospitò la pala di Ludovico Carracci con La Predica del Battista, oggi alla Pinacoteca nazionale. Le decorazioni delle pareti si devono al pittore ornatista Luca Bistega (1672 - 1732).Antonella MampieriVedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/cappella-di-san-giuseppe-863-opera)
Controfacciata
Navata
La chiesa presenta una semplice pianta a tau rovesciato con un'unica navata di tre campate a crociera, illuminata da oculi con vetrate policrome che hanno sostituito le monofore a sesto acuto di cui si possono ancora riconoscere le tracce nel parato esterno. Sulle volte delle due campate più vicine alla cappella maggiore compaiono tracce delle originali decorazioni a motivi vegetali con oculi da cui si affacciano figure di santi. La campata d'ingresso è caratterizzata da una chiave di volta affrescata con la colomba, simbolo dello Spirito Santo. Antonella MampieriVedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/certosa/navata-2064-opera)
Sancta Sanctorum
Le due porte laterali, che danno accesso al Sancta Sanctorum, sono anch'esse decorate con dipinti del Cesi raffiguranti i santi Lorenzo e Stefano. Vedi altro: [www.storiaememoriadibologna.it](https://www.storiaememoriadibologna.it/cappella-maggiore-845-opera)
Flagellazione di Cristo
Clicca sull´icona "Virtual Staging" per vedere la collocazione attuale
Approfondimenti: Pinacoteca Nazionale di Bologna
Coronazione di spine
Clicca sull´icona "Virtual Staging" per vedere la collocazione attuale
Approfondimenti: Pinacoteca Nazionale di Bologna
Altare delle reliquie
Approfondimenti: www.storiaememoriadibologna.it
Amico Aspertini - spalierata
scoperta nella Sacrestia della chiesa di S. Girolamo della Certosa, ora nella cappella delle Reliquie.
Approfondimenti: www.storiaememoriadibologna.it
Amico Aspertini - spalierata
scoperta nella Sacrestia della chiesa di S. Girolamo della Certosa, ora nella cappella delle Reliquie.
Approfondimenti: www.storiaememoriadibologna.it
Predica del Battista
Ludovico Carracci (Bologna 1555-1619)Attualmente si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna
San Bruno in adorazione della Madonna col Bambino in gloria
Barbieri Giovan Francesco detto il Guercino - (Cento 1591-Bologna 1666)Attualmente si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna
Apparizione a San Bruno
Bartolomeo Cesi (1556-1629)Clicca sull´icona "Virtual Staging" per vedere la collocazione attuale
Approfondimenti: Storia e memoria di Bologna
Giudizio Finale
Domenico Maria Canuti (1626-1684) - Foto Oriana Palermo.
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Ascensione di Cristo
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
San Giovanni
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
San Luca
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Paliotto in scagliola
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Via Crucis
Restauro: Ottorino Nonfarmale - Foto: Alberto Martini
Vedi altro: Beni Culturali
Via Crucis
Restauro: Ottorino Nonfarmale - Foto: Alberto Martini
Vedi altro: Beni Culturali
Annunciazione
- Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Monumento funerario Bevilacqua - 1896
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Lapide medievale - 1311
Lapide medievale
S. Antonio da Padova
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
La Predica del Battista
Ludovico Carracci (Bologna 1555-1619)
Ultima cena
Lorenzo Sabatini (1530 circa - 1576), Ultima cena . - Foto Roberto Martorelli
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Cattedra con San Petronio e il Beato Niccolò Albergati
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Sancta Sanctorum
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Ultima Comunione di san Girolamo - 1592
Vedi altro: Pinacoteca Nazionale di Bologna
Monumento al Cardinale Moretti
Il monumento al Cardinale Moretti scolpito da Enrico Barberi (1850-1941) nel 1883 su progetto di Alfredo Tartarini (1845-1905) - Foto Oriana Palermo.
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Paliotto in scagliola
Paliotto seicentesco in scagliola - Domenico Pianon - fine XVII secolo - Foto Alberto Martini
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Francesco Gessi - Pesca Miracolosa
Francesco Gessi (1588–1649), Pesca Miracolosa, 1645. Bologna (foto R. Martorelli)
San Bruno
Jacopo Alessandro Calvi detto il Sordino (1740 - 1815), San Bruno, attr.
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
San Matteo
Nunzio Rossi (1626 – post 1651), San Matteo , 1644 ca.- Foto Roberto Martorelli.
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
San Marco
Nunzio Rossi (1626 – post 1651), San Marco , 1644 ca.- Foto Roberto Martorelli
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Battesimo di Cristo
Elisabetta Sirani (1638-1665), il Battesimo di Cristo, 1658. - Foto Oriana Palermo
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Lorenzo Sabatini - Santi Girolamo e Ugo
Lorenzo Sabatini (1530 ca. - 1576) attr. Santi Girolamo e Ugo, dopo il restauro del 2012 - Foto Laboratorio Nonfarmale
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Lorenzo Sabatini - Santi Petronio e Bruno
Lorenzo Sabatini (1530 ca. - 1576) attr. Santi Petronio e Bruno, dopo il restauro del 2012 - Foto Laboratorio Nonfarmale
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Giovanni Andrea Sirani - Cena dal fariseo
Giovanni Andrea Sirani (1610-1670), La Cena in Casa del Fariseo, 1652 - Foto Oriana Palermo
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Giovan Francesco Gessi - Cacciata dei Mercanti
Giovan Francesco Gessi, (1588–1649), Cacciata dei Mercanti dal Tempio, 1648
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Lorenzo Pasinelli - Cristo appare alla Madonna
Lorenzo Pasinelli (1629-1700), Cristo risorto accompagnato dai Padri del limbo appare alla Madre, 1657 - Foto Oriana Palermo
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Lorenzo Pasinelli - Cristo entra a Gerusalemme
Lorenzo Pasinelli (1629-1700), L’ingresso di Gesù in Gerusalemme - Foto Oriana Palermo
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Vivarini - polittico della Certosa di Bologna
Antonio e Bartolomeo Vivarini, il Polittico commissionato per volontà del papa Niccolò V nel 1450 per la Certosa di Bologna.
Trasferito nella Pinacoteca Nazionale.
Clicca sull´icona "Virtual Staging" per vedere l´altare oggi
Foto Roberto Martorelli - Vedi altro: Pinacoteca Nazionale di Bologna
Ercole Graziani (1688-1765) Il Beato Nicolò Albergati appare in sogno a Tommaso Parentucelli
Foto dopo il restauro di Ottorino Nonfarmale
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
La Madonna col Bambino, S. Caterina e S. Ugo Vescovo di Girolamo Bonesi (1653 - 1725)
Foto dopo il resturo di Ottorino Norfarmale
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Bartolomeo Cesi - Crocefissione
Bartolomeo Cesi (1566 - 1629) Crocefissione, Bologna, Chiesa di S. Girolamo della Certosa. (foto laboratorio di restauro O. Nonfarmale)
Francesco Gessi - Santi certosini
Francesco Gessi (1588–1649), due dei quattro Santi certosini dopo il restauro. Si trovano ai lati delle due grandi tele eseguite dallo stesso artista. Bologna, Chiesa di san Girolamo della Certosa. (foto laboratorio di restauro O. Nonfarmale)
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Orazione nell'orto
Bartolomeo Cesi - ca 1595
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Bartolomeo Cesi - Deposizione di Cristo
Bartolomeo Cesi, Deposizione nel Sepolcro. Bologna, Chiesa di S. Girolamo della Certosa.
foto Guido Barbi
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Poena nasci labor vivere necesse mori
Nascere è dolore, vivere è fatica, morire una necessità.Si tratta di un detto medievale, d’ autore incerto,
che si legge nelle opere di S.Bernardo di Chiaravalle:
"Unde superbit homo, cujus concepito culpa
Nasci poena, labor vita, necesse mori?”
e si ritrova spesso negli epitaffi.
Sullo scheletro umano vi è un cartiglio su cui è scritto:
Serius aut citius sedem venietis ad istam
O tardi o presto verrete a questa sede [dei morti]
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Poena nasci labor vivere necesse mori
Poena nasci labor vivere necesse mori
Omnia sint operata Deo
Tutto sia fatto per Dio. Potrebbe riferirsi alla frase di Isaia (26,12):
” Omnia enim opera nostra operatus es nobis ”
che la Bibbia di Gerusalemme traduce:
“Signore, tu dai successo a tutte le nostre imprese”
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
foto di Alberto Martini
I monaci certosini della colonna di sinistra
I monaci certosini della colonna di sinistra
Beato Niccolò Albergati
San Bruno
San Paolo
Il Tabernacolo - 1937
foto di Alberto Martini
San Giovanni Battista
San Girolamo
Bartolomeo Cesi, Santo Stefano, porta laterale altare maggiore
Bartolomeo Cesi, San Lorenzo, porta laterale altare maggiore
San Petronio (1600-1649)
San Bonaventura
Foto Laboratorio di restauro Nonfarmale
Vedi altro: www.storiaememoriadibologna.it
Ille bene vivit qui per Christum mori desiderat.
Forse una citazione da Orazio: “Bene vivit qui bene cenat ”
(Vive bene chi mangia bene)
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
foto di Alberto Martini
Cantate exultate et psallìte
Gridate, esultate con canti di gioia
Salmo 98, (97) 4
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Cantate exultate et psallìte
Gridate, esultate con canti di gioia
Salmo 98, (97) 4
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Benedictio Domini super caput iusti.
La benedizione del Signore sul capo del giusto.
Proverbi. 10, 6
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Domus mea domus orationis vocabitur.
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera.
Isaia. 56, 7/ Matteo 21,13
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
foto di Alberto Martini
Attendite ut fructum plurimum afferatis
Mettete ogni impegno per portare molto frutto
Giovanni 15,8
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Te vox canora concrepat Domine.
Forse un accomodamento al testo di Giosuè 6,9:
"l'avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca; si procedeva a suon di tromba.”
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Non fuit quisquam sanctior Johanne
"Fra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista"
Matteo 11,11
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Psallam spiritu psallam et mente Domino
Canterò al Signore con lo spirito, ma canterò anche con l’intelligenza.
Prima lettera ai Corinzi 14, 15
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Omnia tempus habent
Per ogni cosa c’è il suo momento.
Ecclesiaste 3, 2
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Omnes dii gentium demonia
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Passer invenit sibi domum
Anche il passero trova la casa
[e poi continua: la rondine il nido dove porre i suoi piccoli]
Salmo 84 (83), 4
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
In psalterio dechacordo psallam tibi
Suonerò per te sull’arpa a dieci corde.
Salmo 144 (143),9
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Spectaculum facti sumus
Siamo diventati spettacolo[agli angeli e agli uomini]
Prima lettera ai Corinzi 4,9
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
foto di Alberto Martini
Calicem salutaris accipiam
Alzerò il calice della salvezza [e invocherò il nome del Signore]
Salmo 116 (114-115),13
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
In memoria aeterna erit iustus
Il giusto sarà sempre ricordato
Salmo 112(111),6
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Sant'Antelmo
fotografie di Alberto Martini
I monaci certosini della colonna di destra
foto di Alberto Martini
I monaci certosini della colonna di destra
fotografie di Alberto Martini
Sant' Ugo
fotografie di Alberto Martini
Crocifissione di Cristo - Orazio Samacchini (1532-1577)
Orazio Samacchini (1532-1577), artista molto attivo nella Roma dei Papi dove partecipò coi fratelli Zuccari alla decorazione del Palazzo Apostolico e in particolare della Sala Regia su mandato di papa Pio IV. «L’opera custodita qui in Certosa - spiega ancora padre Mario Micucci - rappresentata la crocifissione di Cristo con ai piedi la Madonna, san Giovanni Evangelista e un santo di cui non si conosce ancora il nome ma del quale, molto probabilmente dopo il restauro, verranno alla luce alcune caratteristiche che ne semplificheranno l’individuazione.Foto dopo il restauro di Ottorino Nonfarmale
San Pietro
foto di Alberto Martini
Habentes solatio sanctos libros
avendo a conforto le sacre scritture
Primo libro dei Maccabei - 12,9
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Hora est de somno surgere
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno
Romani - 13,11
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Tollat unusquisque crucem suam
Ognuno prenda la sua croce [e mi segua]
Luca - 9,23
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Turris fortissima nomen Domini
Torre fortissima è il nome del Signore
Proverbi - 18,10
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Confitebor tibi in cithara
A te canterò con la cetra [Dio, Dio mio]
Salmi - 43,4
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Deus in domibus eius cognoscetur
Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile
Salmi - 48(47),4
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Bestiae et cuncta peccora laudate Dominum
Voi fiere e tutte le bestie lodate il Signore
Salmi - 148,10
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Quae sursum sunt sapite
Pensate alle cose di lassù
Colossesi - 3,1-2
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Sacrificium laudis honorificabit me
Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora
Salmi - 50(49),23
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Gallo canente spes redit
Al canto del gallo (all’inizio del nuovo giorno) rinasce la speranza
È la sesta strofa dell’Inno Aeterne rerum Conditor composto da Sant’Ambrogio, che si leggeva, prima della riforma liturgica, nel Breviario alle Lodi della Domenica; vi si legge ancora; ma la strofa che comincia con questo verso è stata eliminata.
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Gloria et divitiae in domo Domini
Gloria e ricchezze nella casa del Signore
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Psallam Deo meo quamdiu fuero
Loderò il Signore per tutta la mia vita
Salmi - 146(145), 2
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Fulcite me floribus quia amore langueo
Sostenetemi con fiori [ “con focacce d’uva passa”],
perché io sono malata di amore
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Audiam quid in me loquatur Dominus
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Laeticia sempiterna super caput eius
Felicità perenne sarà sul suo capo
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Dormire mentem ne sinas
Non permettere che la mente si addormenti…
È il primo verso della sesta strofa dell’Inno Deus creatorum omnium che si leggeva, prima della riforma liturgica, ai primi vespri della Domenica; vi si legge ancora, ma senza quella strofa.
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
Blasii de Marchis manu.
Giovanni Battista con il cartiglio: Ecce Agnus Dei.
Giovanni - 1,29: Ecco l’Agnello di Dio.
Sotto la firma: Blasii de Marchis manu.
(Per mano di Biagio de March [1538]).
ricerche iconografiche di Padre Mario Micucci
fotografie di Alberto Martini
STAZIONE III
STAZIONE IV
STAZIONE VIII
STAZIONE V
STAZIONE VI
STAZIONE VII
STAZIONE IX
STAZIONE X
STAZIONE XI
STAZIONE XII
STAZIONE XIII
STAZIONE XIV
STAZIONE XIV
Particolare
Particolare
Nativitá
Sacra Famiglia con Sant'Anna
originale nella Chiesa di S. Maria del Castello a Viadana (MN)
Ludovico Carracci, Cristo porta la croce, frammento fine '500
Bartolomeo Cesi, Madonna col Bambino, affresco
San Giovanni Battista
San Girolamo
Controfacciata
L'assetto attuale della controfacciata è del tutto diverso rispetto all'impianto originario seicentesco. Era qui collocato il quadrone rappresentante la Natività, primo dipinto del ciclo cristologico, terminato nel 1644 dal napoletano Nunzio Rossi (1626 - post 1651). Ai lati erano posti due santi certosini del medesimo artista, ora nei depositi della Pinacoteca Nazionale. Nel corso del XIX secolo le tele del Rossi furono spostate per fare posto all'organo realizzato nel 1836 da Alessio Veratti, che doveva adempiere alle necessità liturgiche di una chiesa divenuta sede delle cerimonie funebri del cimitero. La Natività fu collocata nell'originaria Sala del Capitolo, oggi Cappella della Madonne delle Assi. Dopo il recente restauro, per motivi conservativi è stata collocata nella sala d'anticamera del Sindaco di Palazzo d'Accursio. Attualmente ai lati del coro sono collocati due affreschi anticamente strappati dalla Cappella Maggiore. Sono il san Giovanni e il san Girolamo di Bartolomeo Cesi (1566-1629) qui collocati all'inizio del Novecento dopo un passaggio in altri ambienti del cenobio. Ai lati del portale di ingresso si ammirano due tele rappresentanti rispettivamente i santi Petronio e Bruno e Girolamo e Ugo, attribuiti a Lorenzo Sabatini (1530 circa - 1576), provenienti probabilmente dall'originario refettorio del monastero, ora Sala della Pietà del cimitero.Roberto Martorelli
Nativitá
Nunzio Rossi - 1644Palazzo Comunale (Bologna, Palazzo d’Accursio)
Storia e Memoria di Bologna